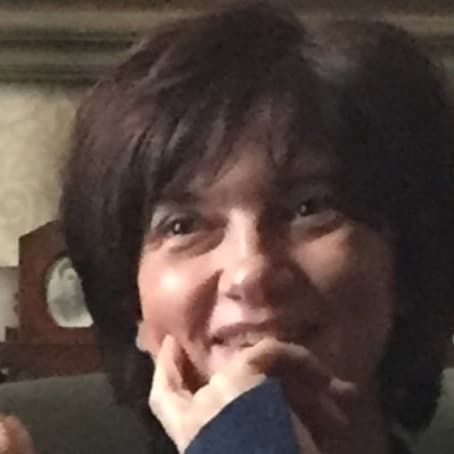Cos’è la depressione post-partum?
La depressione post-partum è una forma depressiva che si manifesta nelle prime settimane o mesi dopo il parto. Si stima che colpisca, con diversi livelli di gravità, dal 10 al 20% delle neo mamme a livello globale.
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) considera la depressione post-partum come un episodio di disturbo depressivo maggiore che esordisce tipicamente nel periodo perinatale, in particolare durante la gravidanza o nelle quattro settimane successive al parto.
In effetti, i criteri diagnostici sono analoghi a quelli della depressione maggiore: umore depresso, perdita di interesse, anedonia, disturbi del sonno e dell’appetito, difficoltà di concentrazione, disturbi psicomotori, affaticamento, senso di colpa o inutilità, che sono presenti per almeno due settimane e creano un disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento che non sono attribuibili a una sostanza o ad un’altra condizione medica.
La depressione post-partum in particolare si caratterizza per dei sentimenti di tristezza e inadeguatezza in merito al nuovo ruolo di mamma, accompagnati da pianto frequente e una variegata sintomatologia che può variare da persona a persona. Anche i livelli di intensità e disagio dipendono da caso a caso: da lievi difficoltà nella gestione del piccolo o nelle relazioni familiari a serie difficoltà nell’affrontare i diversi aspetti della vita in generale.
Come ci fa sentire in un momento che tutti vedono come positivo?
Molti credono erroneamente che la maternità sia un momento che porta esclusivamente gioia e serenità, trattandosi di qualcosa di “naturale” che le donne vivono da secoli. Tuttavia, si tratta di falsi miti. È vero che l’istinto materno esiste, ma non significa che tutte le mamme siano impeccabili ed emotivamente stabili.
La nascita di un bambino può innescare un’ondata di potenti emozioni, anche contrastanti, come eccitazione e gioia da un lato, e paura e ansia dall’altro. La transizione di una donna verso la maternità implica l’apprendimento di un nuovo ruolo, l’adattamento a molti cambiamenti e l’instaurazione di una complessa e ricca relazione con il figlio. Tutto questo non è affatto facile e spesso porta con sé stress e disagio.
Una neomamma, per quanto felice di immedesimarsi nel suo nuovo ruolo, potrebbe provare paura e inadeguatezza, non sentendosi del tutto pronta per il grande cambiamento che sta vivendo. Infatti, nel periodo post-partum, la stragrande maggioranza delle donne presenta un qualche tipo di disturbo dell’umore.
Circa il 70-80% delle neomamme sperimentano un fenomeno transitorio noto come “baby blues”, che si risolve spontaneamente entro una o due settimane dal parto. Il baby blues consiste in sbalzi d’umore, pianto frequente, irritabilità, tristezza, ansia e sentimenti di inadeguatezza. Si tratta di una condizione che deriva dall’estrema stanchezza fisica, lo stress del parto e il repentino cambiamento ormonale.
In una minoranza dei casi, si può sviluppare la depressione post-partum. È simile al baby blues, ma più grave: mentre nel baby blues i sintomi sono lievi e di breve durata, nella depressione post-partum, sono intensi e persistenti.
Nonostante la loro diffusione, si stima che i disturbi dell’umore delle neomamme siano sottodiagnosticati fino al 50% dei casi, perché le donne tendono a nascondere ciò che provano, per via dei forti stereotipi su “come dovrebbe essere” una madre.
Sintomi
Le donne che soffrono di depressione post-partum sperimentano tristezza profonda e pianto frequente, spesso senza un motivo apparente. Tendono a sentirsi inadeguate nel loro nuovo ruolo di madre, credendo di non essere capaci di prendersi cura del bambino. Questo senso di inadeguatezza è spesso accompagnato da una forte stanchezza e mancanza di energia, che persiste anche dopo il riposo.
L’ansia e l’irritabilità possono diventare molto intense e manifestarsi con aggressività e intolleranza, rendendo difficili i rapporti con il partner e la famiglia. Molte donne sviluppano pensieri ricorrenti di colpa, spesso associati alla paura di essere una madre incapace, e possono avere difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni.
Un sintomo chiave è l’anedonia, ovvero la perdita di interesse per le attività che prima davano piacere, inclusa la sfera sessuale. Si possono sperimentare pensieri negativi frequenti, che possono arrivare fino al desiderio di fuga o, nei casi più gravi, anche a idee lesive verso il figlio o autolesive. Infatti, nel 20% dei casi di depressione post-partum insorgono pensieri suicidari.
I disturbi del sonno sono comuni: alcune donne soffrono di insonnia, altre dormono troppo ma senza sentirsi mai riposate.
Anche l’appetito può essere alterato, con una riduzione o un aumento significativo del cibo consumato, con possibili conseguenze sul peso corporeo.
Nel contesto di questa sintomatologia, la bassa autostima e la vergogna giocano un ruolo importante e rendono più difficile la scelta di chiedere aiuto.
In casi rari, circa lo 0.2%, la depressione può evolvere in psicosi post-partum, una condizione estremamente grave che richiede un intervento immediato. Le donne che ne soffrono possono sperimentare allucinazioni visive o uditive, credenze irrazionali (come la convinzione di essere pericolose per il proprio bambino), comportamenti disorganizzati e, nei casi più estremi, pensieri di autolesionismo o di far del male al neonato. La psicosi post-partum si manifesta solitamente entro la prima settimana dopo il parto e richiede un trattamento psichiatrico immediato, che generalmente include il ricovero.
Durata
La durata della depressione post-partum varia da donna a donna e dipende da diversi fattori, come la gravità dei sintomi, il supporto ricevuto e il trattamento intrapreso.
Per essere definita tale, la depressione post-partum ha una durata superiore alle 2 settimane. Generalmente, se trattata opportunamente e con il giusto supporto, dura diversi mesi, dai 3 ai 7 mesi nella media.
Tuttavia, in assenza di trattamento, tende a cronicizzarsi in un disturbo depressivo maggiore e protrarsi fino a un anno o più.
Gli effetti della depressione postpartum sul bambino
Dagli studi è emerso che la depressione postpartum influenza molti comportamenti di accudimento materno; per esempio, riduce le probabilità di allattare al seno e di fare visite mediche e vaccinazioni regolarmente. Le mamme affette da questa condizione non riescono a entrare in sintonia con il bambino, né a riconoscere i suoi segnali di interesse o a supportarne il coinvolgimento con l’ambiente. Per questi motivi, la madre potrebbe diventare poco sensibile, ostile o negligente, e non rispondere correttamente alle esigenze del figlio.
Da qui possiamo dedurre come la depressione post-partum non coinvolga solo la madre, ma anche il figlio. Gli effetti sul bambino possono essere svariati. I principali sono:
attaccamento insicuro con la madre
disregolazione emotiva e ansia
compromissione o ritardo dello sviluppo emotivo, linguistico, sociale e cognitivo, con bassi punteggi di QI
difficoltà relazionali
maggiore iperattività e distraibilità
maggiore rischio di sviluppare disturbi psichiatrici e medici nell’adolescenza
aumentato rischio di infezioni gastrointestinali e del tratto respiratorio inferiore.
Cause
In molti casi, la depressione post-partum è l’evoluzione di una depressione prenatale, cioè sorta durante la gravidanza, che non è stata riconosciuta. Tuttavia, le cause possono essere svariate e l’eziologia si considera multifattoriale.
Ecco i principali fattori che concorrono allo sviluppo di una depressione post-partum:
Fattori biologici: Il cambiamento ormonale caratterizzato dal crollo dei livelli di estrogeni e progesterone causa alterazione dell’umore, con irritabilità e destabilizzazione emotiva.
Fattori genetici: Secondo i risultati di uno studio, la presenza dei geni TTC9B e HP1BP3, importanti per la regolazione dell’umore, possono prevedere se una donna svilupperà depressione post-partum.
Predisposizione familiare o storia di disturbi dell’umore: Una storia personale familiare di depressione o altri disturbi dell'umore aumenta il rischio di sviluppare depressione post-partum del 30-35%.
Bassa autostima materna: Secondo gli esperti, la scarsa autostima esporrebbe le neomamme 39 volte di più ai sintomi depressivi post-partum.
Eventi stressanti: Eventi difficili, in particolare complicanze ostetriche o gravidanze non pianificate, possono essere fattori scatenanti, in quanto generano un forte stress.
Livelli di stress pre-parto: Da uno studio recente è emerso come alti livelli di cortisolo, in particolare nel periodo di preconcezione e nel secondo trimestre di gravidanza, siano correlati positivamente alla depressione post-partum.
Età materna: In uno studio canadese, i ricercatori hanno evidenziato che le donne intorno ai 20 anni e intorno ai 40 anni mostrano un aumento del rischio di sviluppare depressione post-partum.
Parti multipli: Gli studi dimostrano che un parto gemellare o plurigemellare aumenta notevolmente il rischio di depressione post-partum.
Problemi di salute o esigenze speciali del bambino: Una situazione in cui il proprio bambino richiede particolari attenzioni o non gode di una buona salute espone la neomamma ad un aumentato rischio di depressione post-partum.
Difficoltà coniugali: Quando il partner rifiuta la paternità, è poco coinvolto, litigioso, violento o fa uso di alcol, si riscontrano tassi più elevati di depressione post-partum.
Svantaggio socio-economico e scarso supporto sociale: Da studi condotti in paesi in via di sviluppo, è emerso che sia uno scarso livello di benessere e istruzione sia uno scarso sostegno sociale si associano ad un aumento del rischio di depressione post-partum.
Traumi: Avere subito traumi in passato, in particolare abuso sessuale infantile o in età adulta è un altro fattore di rischio per lo sviluppo della depressione post-partum.
Come riconoscerla e curarla?
La depressione post-partum non trattata può non risolversi spontaneamente e cronicizzarsi in un disturbo depressivo persistente. Infatti, il 50% delle madri non trattate risultano ancora depresse dopo 6 mesi dal parto e il 25% delle madri non trattate risultano ancora depresse dopo 1 anno.
Per questo è fondamentale cercare un aiuto professionale nel caso in cui si sospetti la depressione post-partum. Si riconosce per una tristezza persistente, pianto frequente, senso di inadeguatezza come madre, affaticamento estremo, ansia, irritabilità e perdita di interesse per le attività quotidiane. Se questi sintomi durano più di due settimane e interferiscono con la cura del bambino e il benessere personale, è importante chiedere aiuto.
Affiancato al supporto psicologico o alla psicoterapia, in certi casi un medico può aggiungere un intervento farmacologico con medicinali e dosaggi sicuri durante l’allattamento, se lo ritiene necessario.
Anche il supporto sociale è di fondamentale importanza: coinvolgere partner, amici, familiari e partecipare a gruppi di supporto con altre madri può essere di grande conforto e alleviare il carico emotivo della neomamma.
Consigli utili
Il periodo post-partum è molto impegnativo per le neomamme. Per questo, è importante prepararsi e sapere come prevenire la depressione post partum.
Ecco alcuni consigli:
Gruppi di supporto: Confrontarsi e parlare con altre mamme aiuta a sentire che non si è sole, a trovare strategie per affrontare le sfide quotidiane e a vedere le difficoltà da nuove prospettive.
Delegare il più possibile: Coinvolgere il papà e delle altre persone nella cura del bambino permette di ritagliarsi dei momenti per sé stesse.
Ritagliare tempo di qualità con il partner: È fondamentale continuare a nutrire la relazione di coppia, espandendo l’amore al nuovo arrivato, e non togliendolo al partner.
Svagarsi: Trascorrere tempo fuori da casa una volta ogni tanto, per esempio fare una passeggiata, andare a trovare i propri amici o fare un po’ di sport, aiuta a star bene.
Non rimproverarsi: Anche a costo di tralasciare un po’ le pulizie domestiche, è bene dare priorità al proprio benessere. Meglio non essere severe né con sé stesse né con il partner nella gestione delle attività quotidiane.
Come può esserti d’aiuto Psicologi Online?
In questa sezione troverai moltissimi articoli che parlano di psicologia, relazioni, sessualità, benessere emotivo e mentale e molto altro, suddivisi in varie categorie.
Oggi ad esempio abbiamo parlato di depressione post partum.
Se stai attraversando un momento difficile potresti sentire il desiderio di parlare con uno Psicologo.
Con noi puoi farlo in modo molto semplice. A questa pagina puoi trovare un professionista accreditato (psicologo e/o psicoterapeuta) effettuando una ricerca per città o per problematica da risolvere: www.psicologionline.net/psicologi-psicoterapeuti
Preferisci una consulenza a distanza in videochiamata comoda e accessibile? Con Psicologi Online è possibile.
A questa pagina troverai l’elenco dei professionisti che svolgono consulenza psicologica online:
www.psicologionline.net/psicologi-psicoterapeuti-videoconsulenza
Ti basterà trovare un posto tranquillo, avere una connessione internet e la voglia di comprendere meglio cosa ti sta accadendo.
Ognuno di noi incrocia difficoltà specifiche nel viaggio della vita, a prescindere da chi siamo o da quali “lotte” abbiamo combattuto. Il nostro passato è solo un capitolo del nostro libro, non la trama completa, e non ha la potenza di predeterminare le pagine a venire.
Psicologi Online è qui per questo. Clicca sui link qui sopra per trovare il professionista adatto a te pronto ad aiutarti a stare meglio.
Bibliografia
Abulaiti A., Abudurexiti M., Nuermaimaiti A., Kelimu A (2022). Analysis of the incidence and influencing factors of postpartum depression and anxiety: A cross-sectional study in Xinjiang from 2018 to 2021. Journal of Affective Disorders, 302, 15-24.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Avan, B, Richter, LM, Ramchandani, PG, et al. (2010). Maternal postnatal depression and children’s growth and behaviour during the early years of life: exploring the interaction between physical and mental health. Arch Dis Child; 95(9): 690–695.
Brummelte S., Galea L.A (2016). Postpartum depression: Etiology, treatment and consequences for maternal care. Hormones and Behavior. Jan;77:153-66.
Caparros-Gonzalez R., Romero-Gonzalez B., Strivens-Vilchez H., Gonzalez-Perez R., Martinez-Augustin O., Peralta-Ramirez M.I. Hair cortisol levels, psychological stress and psychopathological symptoms as predictors of postpartum depression. PLoS ONE. 2017; 12(8).
DelRosario G.A., Chang A.C., Lee E.D (2013). Postpartum depression: symptoms, diagnosis, and treatment approaches. JAAPA. Feb;26(2):50-4.
Feldman R, Granat A, Pariente C, et al. (2009). Maternal depression and anxiety across the postpartum year and infant social engagement, fear regulation, and stress reactivity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry; 48(9): 919–927.
Glover, V (2014). Maternal depression, anxiety and stress during pregnancy and child outcome; what needs to be done. Best Pract. Res. Clin. Obstet. Gynaecol. 28, 25–35.
Goodman S.H., Rouse M.H., Connell A.M., Broth M.R., Hall C.M., Heyward D (2011). Maternal depression and child psychopathology: a meta-analytic review. Clin Child Fam Psychol Rev. Mar;14(1):1-27.
Hanington, L, Ramchandani P, Stein A. (2010). Parental depression and child temperament: assessing child to parent effects in a longitudinal population study. Infant Behav Dev;33(1): 88–95.
Kaplan PS, Danko CM, Kalinka CJ, et al. (2012). A developmental decline in the learning-promoting effects of infant-directed speech for infants of mothers with chronically elevated symptoms of depression. Infant Behav Dev;35(3): 369–379.
Kiff C.J., Lengua L.J., & Zalewski M (2011). Nature and nurturing: Parenting in the context of child temperament. Clinical Child and Family Psychology Review, 14(3), 251–301.
Kingston D., Tough S., Whitfield H (2012). Prenatal and postpartum maternal psychological distress and infant development: a systematic review. Child Psychiatry Hum. Dev. 43, 683–714.
Lovejoy M.C., Graczyk P.A., O’Hare E, Neuman G (2000). Maternal depression and parenting behavior: a meta-analytic review. Clin Psychol Rev. Aug;20(5):561-92.
Murray L., Cooper P.J., Wilson A., Romaniuk H (2003). Controlled trial of the short- and long-term effect of psychological treatment of post-partum depression: 2. Impact on the mother–child relationship and child outcome. Br. J. Psychiatry 182, 420–427.
Patel V, Rodrigues M, DeSouza N. Gender, Poverty, and postnatal depression: a study of mothers in Goa, India. Am J Psychiatry 2002;159:43–7.
Pearlstein T, Howard M, Salisbury A, et al. (2009). Postpartum depression. Am J Obstetr Gynecol; 200(4): 357–364.
Quevedo, L.A., Silva, RA, Godoy R, et al. (2012). The impact of maternal post-partum depression on the language development of children at 12 months. Child Care Health Dev; 38(3): 420–424.
Shorey S., Chee C.Y.I., Ng E.D., Chan Y.H., Tam W.W.S., Chong Y.S (2018). Prevalence and incidence of postpartum depression among healthy mothers: A systematic review and meta-analysis. J Psychiatr Res. Sep;104:235-248.
Slomian J., Honvo G., Emonts P., Reginster J-Y., Bruyère O (2019). Consequences of maternal postpartum depression: A systematic review of maternal and infant outcomes. Women’s Health.,15.
Stewart D.E, Vigod S.N (2019). Postpartum Depression: Pathophysiology, Treatment, and Emerging Therapeutics. Annu Rev Med. Jan 27;70:183-196.
Stein A, Malmberg L-E, Sylva K, et al. (2008). The influence of maternal depression, caregiving, and socioeconomic status in the post-natal year on children’s language development. Child Care Health Dev; 34(5): 603–612.
Vigod, S.N., Tarasoff, Lesley A., Bryja, B., Dennis, C., Yudin, M., L Ross, L. (2013). Relation between place of residence and postpartum depression, CMAJ, 185(13), 1129-1135; DOI: 10.1503/cmaj.122028.
Walker MJ, Davis C, Al-Sahab B, et al. (2013). Reported maternal postpartum depression and risk of childhood psychopathology. Matern Child Health J; 17(5): 907–917.
Wikenius E, Moe V, Kjellevold M, Smith L, Lyle R, WaagbøR, et al. The association between hair cortisol and self-reported symptoms of depression in pregnant women. PLoS ONE. 2016; 11(9).